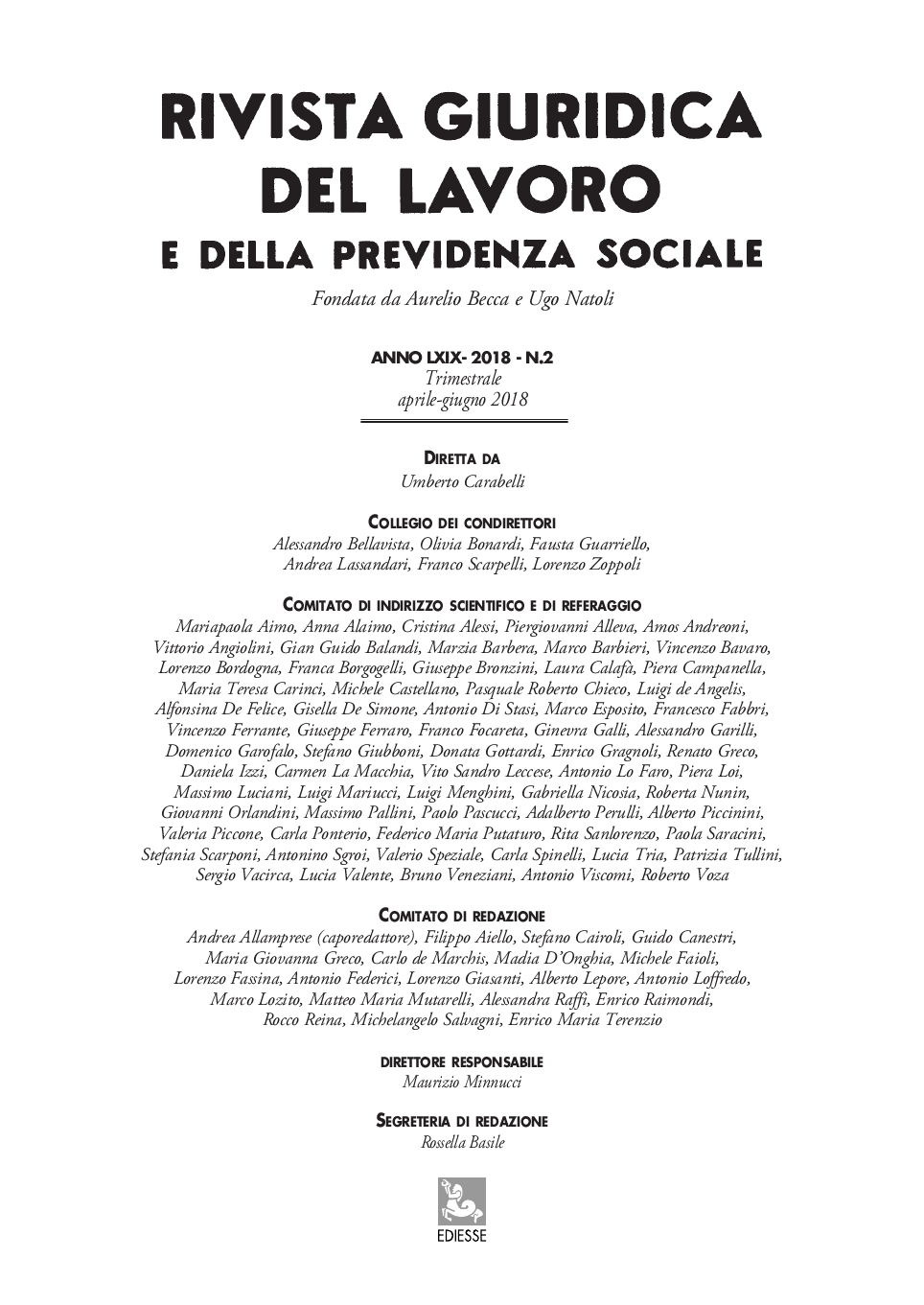TIPOLOGIE VECCHIE E NUOVE DI DEMANSIONAMENTO E TECNICHE DI TUTELA
Carlo Pisani
Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2018
Sommario: 1. Le tipologie di demansionamento vietato sotto la vigenza del precedente art. 2103 cod. civ. e le deroghe giurisprudenziali all’equivalenza – 2.Le fattispecie consentite di demansionamento e quelle vietate dal nuovo art. 2103 cod. civ. – 3. Tecniche di tutela nei confronti del demansionamento e della omessa formazione: a) autotutela, eccezione di adempimento, non imputabilità dell’inadempimento – 4. segue: b) le altre tecniche di tutela di diritto comune: azione di adempimento e risarcimento del danno – 5. L’onere della prova.
1. Le tipologie di demansionamento vietato sotto la vigenza del precedente art. 2103 cod. civ. e le deroghe giurisprudenziali all’equivalenza
Fino al 24 giugno 2015, con il termine demansionamento si indicava il mutamento delle mansioni disposto in violazione della regola dell’equivalenza prevista dall’art. 2103 cod. civ., comma 1, nel testo precedente a quello novellato dall’art. 3 del d. lgs. n. 81/2015, entrato in vigore appunto il 25 giugno 2015, che a sua volta era stato novellato nel 1970 dall’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori rispetto al testo originario del codice civile del 1942[1].
Per una migliore comprensione della nuova disciplina è necessario dare conto sinteticamente degli assetti interpretativi consolidati sotto la precedente normativa, poiché il legislatore ha inteso rimuovere o correggere le incongruità e le rigidità che erano emerse in quarantacinque anni di applicazione dell’art. 13 Stat. lav.
La regola dell’equivalenza si configurava come limite legale all’esercizio dello jus variandi del datore di lavoro, ma anche all’autonomia negoziale delle parti, considerata la inderogabilità della norma, rafforzata dalla espressa previsione dei patti contrari di cui al comma 2.
La violazione di tale precetto legale poteva essere realizzata mediante tre modalità.
A) L’adibizione a mansioni inferiori, e cioè inquadrate dal contratto collettivo in un livello inferiore rispetto a quello spettante al lavoratore in base alle ultime mansioni svolte; l’inferiore inquadramento delle nuove mansioni era ritenuta circostanza sufficiente per sancire la violazione della norma e quindi assorbente rispetto all’indagine se le nuove mansioni fossero o no equivalenti anche da un punto di vista professionale con le precedenti[2].
B) L’adibizione a mansioni non inferiori, perché inquadrate nello stesso livello dal contratto collettivo, ma che non consentivano al lavoratore di conservare il bagaglio professionale acquisito nella fase pregressa del rapporto[3]. In estrema sintesi, al di là di qualche isolata sentenza[4], secondo la prevalente giurisprudenza la norma avrebbe imposto, come è stato efficacemente affermato, che “il tornitore rimanesse per sempre tornitore, il gruista per sempre gruista”[5], con un’ “attenzione spasmodica” alla conservazione della professionalità acquisita[6].
C) La sottrazione delle mansioni, cioè la privazione totale dei compiti lavorativi, per cui il lavoratore viene lasciato sostanzialmente inutilizzato, oppure la sottrazione parziale, ma con riduzione qualitativa tale da determinare una sottoutilizzazione professionale del dipendente[7]. Qui la giurisprudenza si è spinta ad affermare che tale fattispecie sarebbe estranea alla regola dell’equivalenza poiché riconosce addirittura un diritto generalizzato del lavoratore all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, ricavandolo direttamente dagli artt. 2, 4 e 35 Cost.[8] Secondo questo orientamento la prestazione lavorativa non costituirebbe soltanto un obbligo del dipendente nell’ambito dello scambio tipico del contratto di lavoro subordinato, ma diverrebbe anche, appunto, un diritto, poiché il lavoro non rappresenterebbe solo un mezzo si sostentamento e di guadagno ma altresì un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore. Dal punto di vista del demansionamento, la differenza risiede nel fatto che, se si riconosce un tale diritto generalizzato, in caso di sottrazione delle mansioni l’illecito contrattuale si verifica automaticamente a prescindere dal fatto se la forzata inattività abbia comportato o no la dispersione del patrimonio professionale del lavoratore; se, invece, si nega tale diritto, l’illecito si configura solo se nel caso concreto sia dimostrabile un effettivo vulnus al “saper fare” del dipendente.
Parte non trascurabile della dottrina si è però mostrata restia a riconoscere un simile diritto generalizzato[9] oltre i casi particolari in cui esso sia desumibile dal contratto individuale di lavoro, come, ad esempio, per il lavoro sportivo o artistico, ovvero allorquando tale diritto sia ricavabile da norme speciali, come avviene nell’apprendistato o nel patto di prova. Si è sostenuto, condivisibilmente, che, da un punto di vista civilistico, il principio costituzionale di realizzazione della persona umana mediante il lavoro non sembra annoverare l’obbligo del datore di lavoro di utilizzare effettivamente il dipendente[10], giacché “lo Statuto del lavoratori non ha introdotto alcun elemento di modifica nella struttura dello scambio del rapporto. Lo Statuto ha profondamente modificato il potere organizzativo dell’imprenditore, ma queste modifiche non alterano nessun elemento del contratto”[11].
Il precedente testo dell’art. 2103 non prevedeva eccezioni o deroghe espresse alla suddetta regola dell’equivalenza; il che rendeva ancor più rigida l’applicazione della norma. La tecnica normativa utilizzata, infatti, era quella di regolare uniformemente l’intero fenomeno della mobilità orizzontale del lavoratore, e cioè ogni tipo di mutamento delle mansioni che non fosse verso compiti superiori, mediante un’unica regola a precetto generico, appunto l’equivalenza.
Da un punto di vista sistematico, a livello di tecniche normative, si può azzardare un accostamento con il vecchio testo dell’art. 18 Stat. lav.: anche lì si applicava la medesima uniforme massima sanzione a tutti i possibili vizi o motivi di illegittimità del licenziamento, dalla più lieve violazione formale al più odioso licenziamento discriminatorio. Ed infatti, come è accaduto per l’art. 2103, anche in relazione all’art. 18 Stat. lav., il legislatore del Jobs Act è intervenuto provvedendo a diversificare la disciplina a seconda delle differenti situazioni, allentandone così la rigidità.
Solo in casi molto particolari alcune norme stabilivano, e stabiliscono tutt’ora non essendo state abrogate, specifiche deroghe all’equivalenza, per lo più nell’interesse del lavoratore[12]. La tassatività del divieto di patti contrari di cui al comma 2 dell’art. 2103 c.c. era tale da creare una serie di problemi interpretativi, puntualmente emersi in giurisprudenza. Si manifestava qui lo «scontro inesorabile»[13] tra l’estrema rigidità dell’assetto garantistico della norma e le esigenze di elasticità rispondenti alle volte anche all’interesse del lavoratore. Sicché l’interprete si trovava continuamente di fronte al dilemma se far prevalere o no sul dato letterale della disposizione l’argomento del «legislatore ragionevole», secondo cui si deve escludere quella lettura dell’enunciato che dia luogo ad una norma «assurda»[14].
Si comprende così perché la giurisprudenza era stata indotta ad introdurre progressivamente, sia pure con oscillazioni, alcune eccezioni alla regola dell’equivalenza, ricavate in via interpretativa.
Alcune sentenze della Cassazione avevano sostenuto una sorta di «affievolimento» del diritto del lavoratore all’esercizio di mansioni equivalenti in presenza di serie e ragionevoli esigenze di efficienza aziendale[15], giustificando anche la totale inutilizzazione del lavoratore nel caso in cui il datore, nella sua veste di debitore “di equivalenza”, dimostrava che ciò era dipeso da fattori oggettivi estranei alla sua volontà e legati alla generale contrazione delle attività imprenditoriali[16]; con simili argomentazioni si era giunti ad affermare che “l’adibizione a mansioni inferiori, rispetto a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retributivo, non si poneva in contrasto con le previsioni del codice civile”, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali comportanti, tra le altre, ristrutturazioni aziendali, poiché, a dire della Cassazione, si concretizzerebbero in tal modo le comprovate esigenze tecnico-produttive che legittimano lo jus variandi[17].
Questa ricerca, effettuata da una parte della giurisprudenza, di “giuste” esigenze aziendali che avrebbero consentito una parziale deroga alla (o un ampliamento della) regola dell’equivalenza, se comprensibile da un punto di vista pratico, per disinnescare quel contenzioso giudiziale riguardante casi di parziale demansionamento che speculava sulla rigidità dell’interpretazione prevalente, non trovavano però riscontro nel tenore letterale della norma, che non consentiva di ipotizzare una sorta di “giustificato motivo oggettivo” di deroga all’equivalenza. Infatti, nel precedente testo dell’art. 2103 cod. civ., era stato abolito il riferimento alle “esigenze dell’impresa” che invece nel testo ante 1970 fungeva da criterio di giustificazione dello jus variandi[18]. Sicché, questa modifica della norma non poteva essere ignorata reintroducendo in via interpretativa la regola di giustificazione per la modificazione in pejus delle mansioni, anche perché nello stesso primo comma dell’art. 2103 cod. civ., nel terzo periodo era invece espressamente prevista la necessaria giustificazione a proposito del trasferimento del lavoratore, così inequivocabilmente dimostrando che, laddove il legislatore aveva voluto condizionare ad una giustificazione obiettiva l’esercizio di un potere modificativo aveva provveduto a sancirlo espressamente.
Un’eccezione alla regola dell’equivalenza ribadita costantemente da una giurisprudenza che poteva definirsi consolidata, era configurabile quando lo spostamento in pejus si presentava come l’unica alternativa per evitare il licenziamento, e solo in quanto tale veniva ritenuto legittimo[19]. Era una flessibilità consensuale attuata a livello individuale, come extrema ratio, quale male minore per il lavoratore al fine di salvaguardare un bene più prezioso della professionalità quale è quello della stessa occupazione.
È evidente che la giurisprudenza si vedeva costretta a forzare il testo della norma per evitare conseguenze contraddittorie per gli interessi del soggetto che la norma stessa intendeva proteggere. Non v’era dubbio, infatti, che il tenore letterale della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 2103 c.c., nella sua tassatività («ogni patto contrario è nullo») era molto chiaro e non sembrava consentire margini interpretativi per ricavarne eccezioni o deroga di sorta. D’altra parte era altrettanto indubbio che dal punto di vista pratico sarebbe stato irragionevole non lasciare al lavoratore la possibilità di scegliere se salvare l’occupazione anche a prezzo della dequalificazione.
Altra tipica creazione giurisprudenziale, al fine di aggirare il divieto di patti contrari di cui al comma 2 dell’art. 2103 c.c., era ravvisabile in quelle sentenze che, partendo dall’assunto che la nullità prevista dal comma 2 dell’art. 2103 c.c. «riguardi soltanto quei patti che regolano l’esercizio dello jus variandi», giungevano a sostenere che tale nullità non operava «nel caso in cui il mutamento di mansioni sia stato disposto a richiesta del lavoratore, per soddisfare un proprio interesse e quindi senza alcuna sollecitazione neppure indiretta del datore di lavoro»[20].
Qui, dunque, non si trattava più di ammettere eccezionalmente la deroga soltanto quando essa era il solo modo per salvare il posto al dipendente, ma anche più genericamente in tutti i casi in cui il patto era volto a procurare al lavoratore un altro tipo di vantaggio, qualunque esso fosse. Anzi, a ben vedere, condizione di validità del patto risiedeva, ancora più semplicemente, nel fatto che esso fosse stato “richiesto” dal lavoratore, e cioè che la proposta negoziale fosse stata avanzata da quest’ultimo; mentre la configurabilità di un vantaggio del lavoratore sembrava rilevare più che altro per escludere una “sollecitazione” da parte del datore di lavoro. In altri termini, i “motivi” che spingevano il lavoratore a concludere il negozio diventavano rilevanti solo al fine dell’accertamento della “genuinità” della sua proposta e quindi del suo consenso.
Questo orientamento rappresentava la definitiva ribellione, in un certo senso inevitabile, della giurisprudenza nei confronti dell’eccessiva rigidità della norma. Come tutte le “creatività” giurisprudenziali, essa lasciava spazio a qualunque tipo di soggettivismo giudiziario, tant’è vero che, dopo una serie di pronunce in senso contrario, la Cassazione aveva deciso di cambiare opinione affermando la inderogabilità assoluta della norma dell’equivalenza, anche quando lo spostamento era stato effettuato a richiesta e nell’interesse del lavoratore[21].
[1] La nuova norma si applica anche ai mutamenti di mansioni disposti prima del 25 giugno 2015 in atto ancora dopo quella data: Trib. Roma, 30 settembre 2015, n. 8195, in Mass. giur. lav., 2015, n. 11, 777; contra Trib. Ravenna 22 settembre 2015, ivi, 2016, n. 3, 152, secondo cui invece la nuova disciplina non si applica allorquando l’adibizione del lavoratore alle nuove mansioni sia avvenuta si antecedentemente al 25 giugno 2015 anche se poi si protragga oltre tale data.
[2] Cfr. per tutte, Cass. 25 gennaio 2006, n. 1388, in Guida lav., 2006, 36; Cass. 6 giugno 1995, n. 6333, in Notiziario giuridico lav., 1995, 732; Cass. 17 marzo 1990, n. 2251, in Rep. Foro it., 1990, Lavoro (Rapporto), n. 746; Cass. 23 gennaio 1998, n. 539, in Notiziario giuridico lav., 1998, 313; Cass. 16 luglio 1986, n. 4602, in Rep. Foro it., 1986, Lavoro (Rapporto), n. 833; Cass. 18 maggio 1984, n. 3076, in Giust. civ., 1985, I, 115; Cass. 5 aprile 1984, n. 2231, in Riv. it. dir. lav., 1984, II, 786. In dottrina, per tutti, F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, Milano, 1982, 178; E. GHERA, Diritto del lavoro, Bari, 1985, 207 ss.
[3] Giurisprudenza costante e straripante; tra le più recenti che ribadiscono l’orientamento rigido, Cass. 22 febbraio 2016, n. 3422 e Cass. 23 febbraio 2016, n. 3485, in Riv. it. dir. lav., 2016, II, 494; Cass. 4 agosto 2015, n. 17624, in Guida lav., 2014, n. 37, 48; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1916, secondo cui le mansioni devono essere aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente senza che assuma rilievo l’inquadramento formale tra le vecchie e le nuove mansioni. Conformi Cass. 3 marzo 2016, n. 4211, in Guida lav., 2016, n. 14, 28; Cass. 23 maggio 2013, n. 12725, in Guida lav., 2013, n. 26, 33; Cass. 24 giugno 2013, n. 15769, in Riv. giur. lavoro, 2013, II, 611; Cass. 14 giugno 2013, n. 15010, in Rep. Foro it., 2013, Lavoro (Rapporto), n. 892.
[4] Cass. 16 giugno 2009, n. 13941, in Mass. giur. lav., 2010, n. 4, 122.
[5] Così F. LISO, La mobilità, op. cit., 175. Per una critica a tale orientamento giurisprudenziale: C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento delle mansioni, Giappichelli, Torino, 2015, 15 ss.
[6] Così A. PALLADINI, La mobilità del lavoro in azienda: recenti tendenze giurisprudenziali e contrattazione di prossimità, in Mass. giur. lav., 2012, n. 3; G. IANNIRUBERTO, Jus variandi orizzontale e nuovo art. 2103 c.c., in Mass. giur. lav., 2016, 261; M. BROLLO, La mobilità professionale dei lavoratori dopo il Jobs Act, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 309.
[7] Cass. 11 luglio 2005, n. 14496, in Mass. giur. lav., 2006, 1-2, 66, 8, la quale precisa che non ogni modificazione quantitativa delle mansioni è sufficiente ad integrare il demansionamento, dovendo invece farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e nella sua collocazione nell’ambito aziendale. Conformi Cass. 18 maggio 2012, n. 7963, in Mass. giur. lav., 2013, 300; Cass. 24 aprile 2007, n. 9865, in Guida lav., 2007, n. 34, 40; Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405, in Foro it., 1995, I, 3133; Cass. 1° giugno 2002, n. 7967, in Mass. giur. lav., 2002, 664; Cass. 11 gennaio 1995, n. 276, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, 825. È stato ritenuto dequalificante per un dirigente la suddivisione con un altro lavoratore delle mansioni precedenti da Cass. 5 maggio 2004, n. 8589, in Guida lav., 2004, n. 25, 44; oppure la minor rilevanza del suo “ruolo”, da Cass. 24 aprile 2007, n. 9865, ivi, 2007, n. 34, 40.
[8] Cfr. Cass. 18 maggio 2012, n. 7963, in Mass. giur. lav., 2013, 300, che ricava a fortiori dalla regola dell’equivalenza il diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835, in Mass. giur. lav., 2010, 222; Cass. 17 settembre 2008, n. 23744, in Arg. dir. lav., 2009, I, 131, si spinge addirittura a sostenere l’esistenza di un diritto soggettivo all’esecuzione della prestazione lavorativa anche per il lavoratore autonomo. Per il diritto allo svolgimento della prestazione del lavoratore subordinato, cfr., inoltre, Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, in Mass. giur. lav., 2007, 1-2, 33; Cass. 5 ottobre 2004, n. 19899, in Guida lav., 2004, n. 46, 54; Cass. 1° giugno 2002, n. 7967, in Riv. it. dir. lav., 2002, 5, 39; Cass. 3 giugno 1995, n. 6265, in Foro it., 1996, I, 1000; Cass. 13 agosto 1991, n. 8835, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 954. Così, ad es. Cass. 12 aprile 2012, n. 7963, in Riv. it. dir. lav., 2013, II, 104; Cass. 21 maggio 2009, n. 11835, in Mass. giur. lav., 2010, 222. Invece ribadisce che sia l’attribuzione del lavoratore a mansioni inferiori, sia il mancato affidamento di qualsiasi mansione sono entrambe situazioni in cui si risolve la violazione dell’art. 2103, Corte Cost., 6 aprile 2004, n. 113, in Mass. giur. lav., 2004, 588.
[9] Cfr. E. GHERA, Le sanzioni nella tutela del lavoro subordinato, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 1979, 330 ss.; E. GRANDI, Lavoro (rapporto), Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987, 337 ss.; M. DELL’OLIO, Licenziamenti illegittimi e provvedimenti giudiziari, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 1987, 433; A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, Padova, 1995, 118; Id., Spunti critici sulla questione del diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione, in Riv. it., dir. lav., 1996, II, 364, che distingue il caso, vietato dall’art. 2103 c.c., in cui il lavoratore venga tenuto in azienda senza alcun compito, da quello, ritenuto invece legittimo, in cui il dipendente, pur retribuito, venga completamente esonerato dallo svolgimento della prestazione e gli venga completamente restituita tutta la sua libertà. Ciò in quanto non sussisterebbe un generale diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione. Per quest’ultima conclusione in dottrina, tra gli altri, S. MAGRINI, Lavoro (contratto individuale), Enc. Dir., XXIII, Milano, 384 e nt. 79; L. FERLUGA, Tutela del lavoratore e disciplina delle mansioni, Milano, 2012, 115; G. GHEZZI, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, 1965, 738; già L. BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, 513; C. M. BIANCA, Le obbligazioni, IV, Milano, 200, 46; A. DI MAJO, voce Obbligazioni, Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, 22. In senso favorevole invece alla configurabilità di un generale diritto del lavoratore all’esecuzione della prestazione, R. SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro, Napoli, 1994, 217 ss; G. SANTORO PASSARELLI, Intervento, in Le sanzioni nella tutela del lavoro subordinato, Atti del VI Congresso nazionale di diritto del lavoro, Alba 1-3 giugno, 1978, Milano, 1979, 129 ss; F. MAZZIOTTI, Il licenziamento illegittimo, Napoli, 1982, 242; E. PERA, Sul diritto del lavoratore a lavorare, in Riv. it. dir. lav., 1991, II, 388; L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra principi costituzionali, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 2007, n. 4, 593.
[10] Così A. VALLEBONA, Istituzioni di diritto del lavoro, II, Il Rapporto di lavoro, Padova, 2012, 184.
[11] Così L. MENGONI, Le modificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello Statuto dei lavoratori, in Diritto e Valori, Bologna, 1985, 377.
[12] La prima è solo temporanea, riguardando le lavoratrici madri che durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, se il tipo di attività o le condizioni ambientali sono pregiudizievoli per la salute, devono essere spostate ad altre mansioni eventualmente anche inferiori a quelle abituali, con conservazione della retribuzione precedente (art. 7, comma 4, d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Un’altra eccezione concerne i lavoratori in esubero nelle procedure di mobilità, il cui licenziamento può essere evitato mediante un accordo collettivo che consenta la loro adibizione a mansioni diverse anche inferiori alle precedenti (art. 4, comma 11, l. 23 luglio 1991, n. 223). Anche per le procedure di mobilità per le società partecipate pubbliche, l’art. 1, comma 567-bis, l. n. 147/2013, prevede che i lavoratori rimasti in esubero al termine della procedura di mobilità, possano chiedere di essere ricollocati in una qualifica inferiore presso la società che ha attivato la procedura o in altra società. Infine, i lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto possono essere licenziati solo se sia impossibile utilizzarli in mansioni disponibili in azienda anche inferiori, con diritto alla conservazione del trattamento della precedente qualifica.
[13] A. GRANDI, La mobilità interna, AA. VV., Strumenti e limiti della flessibilità, Milano, 1986, 292.
[14] G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 369 ss.
[15] Cass. 12 luglio 2002, n. 10187, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 53. Contra, affermano espressamente che non esiste un affievolimento del diritto dell’equivalenza, Cass. 12 giugno 2015, n. 12253, in Guida lav., n. 32-33, 59; Cass. 26 luglio 2006, n. 17022, in Mass. giur. lav., 2007, 24; Cass. 8 agosto 1987, n. 6852, in Mass. giur. lav., 1987; Cass. 8 settembre 1988, n. 5092, in Notiziario giurispr. lav., 1988, 775. Secondo Cass. 21 gennaio 2010, n. 1575, in Mass. giur. lav., 2010, 339, anche nel caso in cui le precedenti mansioni si siano esaurite e quindi non siano state affidate ad altro lavoratore, si può avere demansionamento ove le nuove mansioni siano inferiori a quelle ultime svolte. Neppure il rifiuto preventivo del lavoratore contro il trasferimento giustificato da ragioni organizzative autorizza il datore di lavoro a privare il lavoratore delle sue mansioni: cfr. Cass. 12 aprile 2012, n. 5780, in Mass. giur. lav., 2012, 47, 875.
[16] Cass. 12 aprile 2012, n. 7963, in Riv. it. dir. lav., 2013, II, 104; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832, Lex 24; Cass. 2 agosto 2006, n. 17564, in Foro it., Rep. 2006, voce Lavoro (Rapporto), n. 999.
[17] Cass. 22 maggio 2014, n. 11395, in Guida lav., 2014, n. 29, 31.
[18] Sia consentito, per brevità e anche per la bibliografia di riferimento, il richiamo a C. PISANI, La modificazione delle mansioni, F. Angeli, Milano, 1996, 70 ss.
[19] Cfr., ad es., Cass. 26 gennaio 2010, n. 1575, in Guida lav., 2010, n. 10, 35; Cass. 25 novembre 2010, n. 23926, ivi, 2011, n. 6, 34; Cass. 5 aprile 2007, n. 8596, ivi, 2007, n. 25, 43; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19686, ivi, 2005, n. 49, 31; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375, in Mass. giur. lav., 2005, 6, 481; Cass. 9 marzo 2004, n. 4790, in Riv. it. dir. lav., 2004, II, 789; Cass. 13 ottobre 2004, n. 20240, in Guida lav., 2004, n. 49, 25; Cass. 5 ottobre 2000, n. 10339, in Mass. giur. lav., 2000, 1208; Cass. 29 marzo 2000, n. 3827, ivi, 2000, 686.
[20] Cass. 8 agosto 2011, 17095, in Guida lav., 2011, n. 41, 24; Cass. 20 maggio 1993, n. 5693, in Riv. it. dir. lav., 1994, II, 161; Cass. 2 novembre 1993, n. 10793, ivi, 1994, II, 707; Cass. 24 ottobre 1991, n. 11297, in Notiziario giurispr. lav., 1992, 327; Cass. 1 dicembre 1988, n. 6515, in Mass. giur. lav., 1989, 189, quest’ultima però riferita ad un caso in cui si discuteva di trasferimento anche se poi la sentenza estende le stesse conclusioni anche al mutamento di mansioni.